Intervento al Convegno “Il disagio della cultura nella nostra modernità”, organizzato dal movimento psicanalitico Nodi freudiani, nella tavola rotonda dal titolo “Norma e legalità. Riflessi sulla formazione”, moderata da Franco Quesito (psicanalista, Torino) con la partecipazione di: Simone Berti (psicanalista, Firenze), Piergiorgio Curti (psicanalista, Livorno), Giovanni Callegari (psicanalista, Torino), Moreno Manghi (psicanalista, Pordenone), Antonello Sciacchitano (psicanalista, Milano).
12 ottobre 2013, Palazzo Cusani, Milano
“Noi analisti non operiamo se non nel registro della Versagung.
“Noi entriamo a far parte del destino del soggetto, vi entriamo in qualche modo.”
J. Lacan, Il transfert
“La catastrofe è ogni giorno in cui non accade nulla.”
Letto per caso sui muri di Milano, in via Brera, il giorno del Convegno
Premessa1
Questa mattina li avete ascoltati, Giancarlo Majorino e Ludovica Ripa di Meana: parlavano forse dallo stesso posto da cui hanno parlato tutti gli altri relatori, analisti compresi? No. Non parlavano attraverso degli enunciati – dei pensieri, dei costrutti da comunicare – ma dal posto dell’enunciazione, trovando la cosa da dire al momento, in un dire interamente legato al loro corpo e alle sensazioni che provavano rispetto a coloro che li ascoltavano. In effetti non avevano niente da-dire (le loro idee da trasmetterci), ma parlavano dal posto dell’analizzante, completamente liberi dal discorso universitario, dal “sapere”. Per questo ci hanno commosso e fatto ridere. Ludovica ha tentato di segnalarlo: “Mi sento completamente estranea a ogni forma di discorso intellettuale, non ne sono capace, posso parlare solo delle cose che sento…”; il suo dire procedeva per ricordi, non per concetti, e pertanto era fatto della sua vita. In quanto a Majorino, en passant si è lasciato andare, tra molte, a questa interiezione: “La poesia… eh, la poesia è un’ira di Dio!”
Che cosa fa l’ira di Dio? Distrugge il mondo, il mondo del linguaggio, per ricrearlo ogni volta ex-nihilo, perché è appunto questa la funzione della poesia, quella di custodire nella parola l’ira di Dio. E anche la parola dell’analista dovrebbe custodire l’ira di Dio, affinché questa parola possa avere una qualche efficacia, possa avere il potere di distruggere il mondo in cui ogni giorno non accade niente. Quello di cui vi parlerò è proprio il rifiuto del mondo in cui ogni giorno non accade niente, l’eterna inerzia dello Stesso a cui rimaniamo attaccati con tutti i tentacoli, e il mio desiderio quotidiano di distruggere, senza il quale non potrei fare quello che faccio. L’analista? Non appena lo credo, non appena penso di occupare il posto di analista2, non appena mi convinco di esercitare una professione, ho la certezza che nelle mie analisi non può accadere niente. Ed ecco perché c’è una legge Ossicini: per avere la certezza che i “pazienti” non conosceranno mai l’ira di Dio, e resteranno per sempre pazienti. Dunque il primo rifiuto, la prima Versagung, in quanto analista, è di rifiutare di occupare il posto di analista.
*
Nel lungo commento che dedica, nel seminario Il transfert (1960-61)3, alla trilogia dei Coûfontaine, dramma teatrale di P. Claudel, L’ostaggio, Il pane duro, Il padre umiliato, Lacan osserva che la Versagung ha in Freud un significato completamente diverso da quello che ci è comunemente proposto dalle traduzioni di Freud (sia in inglese che in francese che in italiano), ossia frustrazione, in particolare la frustrazione di una soddisfazione pulsionale. Lacan propone (tra le altre possibili traduzioni di questa parola intraducibile) di tradurre Versagung con rifiuto, o anche: il dire di no. Per Freud la condicio sine qua non, perché un’analisi possa svolgersi, è il rifiutare all’analizzante non solo qualsiasi soddisfazione nella realtà, ma anche qualsiasi soddisfazione egli cerchi di ricavare dalla relazione di transfert: rifiuto di soddisfare la sua domanda d’amore, rifiuto di donare interpretazioni appaganti, che soddisfano la sua pulsione orale, fino al rifiuto di continuare a incarnare il “soggetto supposto sapere” il senso inconscio che all’analizzante sfugge. L’analista, senza mai sottrarsi esplicitamente all’amore di transfert, vi oppone fin dall’inizio un irriducibile quanto dissimulato rifiuto, fino al momento in cui, questo amore di transfert, l’analizzante sarà finalmente pronto ad analizzarlo e così a dissolverlo.
L’analista sa che questa Versagung è insostenibile, poiché l’unico modo in cui può mantenersi nella Versagung, sottraendosi così a tutti i tentativi di essere individuato, identificato, collocato in un posto (qualsiasi esso sia) dall’analizzante, l’unico modo è di essere questo rifiuto, cioè letteralmente di essere un rifiuto, uno scarto. L’unico modo di non occupare un qualsiasi posto tanto nei fantasmi degli analizzanti quanto nell’ordine sociale, è di essere un “rébut de la société”, dice Lacan. Ecco perché potremmo definire la Versagung, con le parole di Claudel, “il pane duro” dell’analista, che è anche il suo pane quotidiano.
Il rifiuto della soddisfazione imposto all’analizzante – questo regime di Versagung senza il quale l’analisi non è possibile – non può allora ridursi a una mera regola tecnica, alla prescrizione di un regime di astinenza, ma è qualcosa che riguarda nel modo più profondo l’ essere dell’analista, a cui ben si addicono tutti e tre gli epiteti del dramma di Claudel: essere l’ostaggio del Verbo o del “significante”, mangiare il pane duro del rifiuto, operare come un padre umiliato, cioè senza più nessuna autorità: né quella della medicina – l’autorità scientifica − né quella della legge – l’autorità giuridica.
Ma cosa ha dunque a che fare la Versagung con il tema che mi è stato chiesto di trattare, Norma e legalità. Riflessi sulla formazione? Cosa significa regolamentare giuridicamente la psicanalisi? – se non dare allo psicanalista un posto, inquadrarlo in una professione, in quel professionismo di cui Freud, in una lettera a Ferenczi, diceva che era l’ultima e la più pericolosa forma di resistenza alla psicanalisi?4 O, con le parole rivolte da Serge Leclaire, che sapeva precorrere i tempi (1965), a J. A. Miller: “Solo una cosa è certa: il giorno in cui l’analista sarà al suo posto non ci sarà più analisi.” (“ L’analyste n’a pas de place et ne peut pas en avoir ”)5. E infatti, oggi che l’analista è più che mai al suo posto, e perfino giuridicamente al suo posto, non ci sono, non possono più esserci analisti (se non fuori dalla legge?)
Due anni dopo il grido di allarme di Leclaire, nella Proposizione del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, Lacan individua nella compunzione ( componction ) il sintomo dello psicanalista promosso socialmente a clerc, cioè non più laico, colui che ha fatto definitivamente della psicanalisi una professione, poiché riceve l’autorizzazione a praticarla da un organo giuridicamente costituito.
Il Robert propone due significati del lemma componction. Il primo è quello corrente: una “gravità raccolta e affettata”, una “seriosità” che bene si addice all’idea che i sacerdoti del clero professionale si sono fatta della loro alta missione. Questa “compunzione” è quella messa in caricatura da Doré, Daumier, Gavarni… Ma dietro il significato corrente, attenuato, rimane nascosto il significato antico e religioso di “compunzione”, che viene dal latino compunctio, da compungere: “pungere”. Così il Robert: Rel. XII sec. : sentimento di tristezza provato davanti alla nostra indegnità al cospetto di Dio: “Provare una viva compunzione dei propri peccati”; contrizione, pentimento (rimorso, mortificazione).
In questo senso, la compunzione dell’analista clerc è quel “resto”, dice Lacan, che “testimonia della formazione mediante cui la psicoanalisi non si dissolve in ciò che propaga” (e cioè la psicoterapia), la cicatrice indelebile della propria formazione psicanalitica.
Ci si impone così un’alternativa radicale tra l’analista che opera nel regime della Versagung, del rifiuto di occupare un qualsiasi posto nell’ordine sociale, a costo di essere un rébut de la société, (l’autorizzarsi da sé a praticare la psicanalisi, la “laicità” dello psicanalista, non può significare altro); e, per contro, l’analista “assetato di rispettabilità (e di legittimità)”, come dice W. Granoff, che abbandona il regime della Versagung per entrare in quello della componction con la sua promozione a clerc.
È nota una delle ultime, se non l’ultima formulazione della Versagung data da Lacan: “Ti domando di rifiutarmi ciò che ti offro perché non è questo”6. Questa invocazione viene attribuita all’analizzante (che chiede che gli venga rifiutato l’amore, per fare posto al desiderio), ma può essere ugualmente attribuita all’analista: Ti domando di rifiutarmi ciò che ti offro – la cura, la terapia, la promessa di guarigione – perché non si tratta di questo, ma (si tratta) di quel “no”, di quella Versagung che finora avevi affidato in custodia al tuo sintomo, anche se mi chiedi di sbarazzartene perché io ti riconsegni, guarito, all’ordine sociale vigente. Ma tutto ciò che io posso fare, è di custodire per te, tuo malgrado, questo rifiuto.
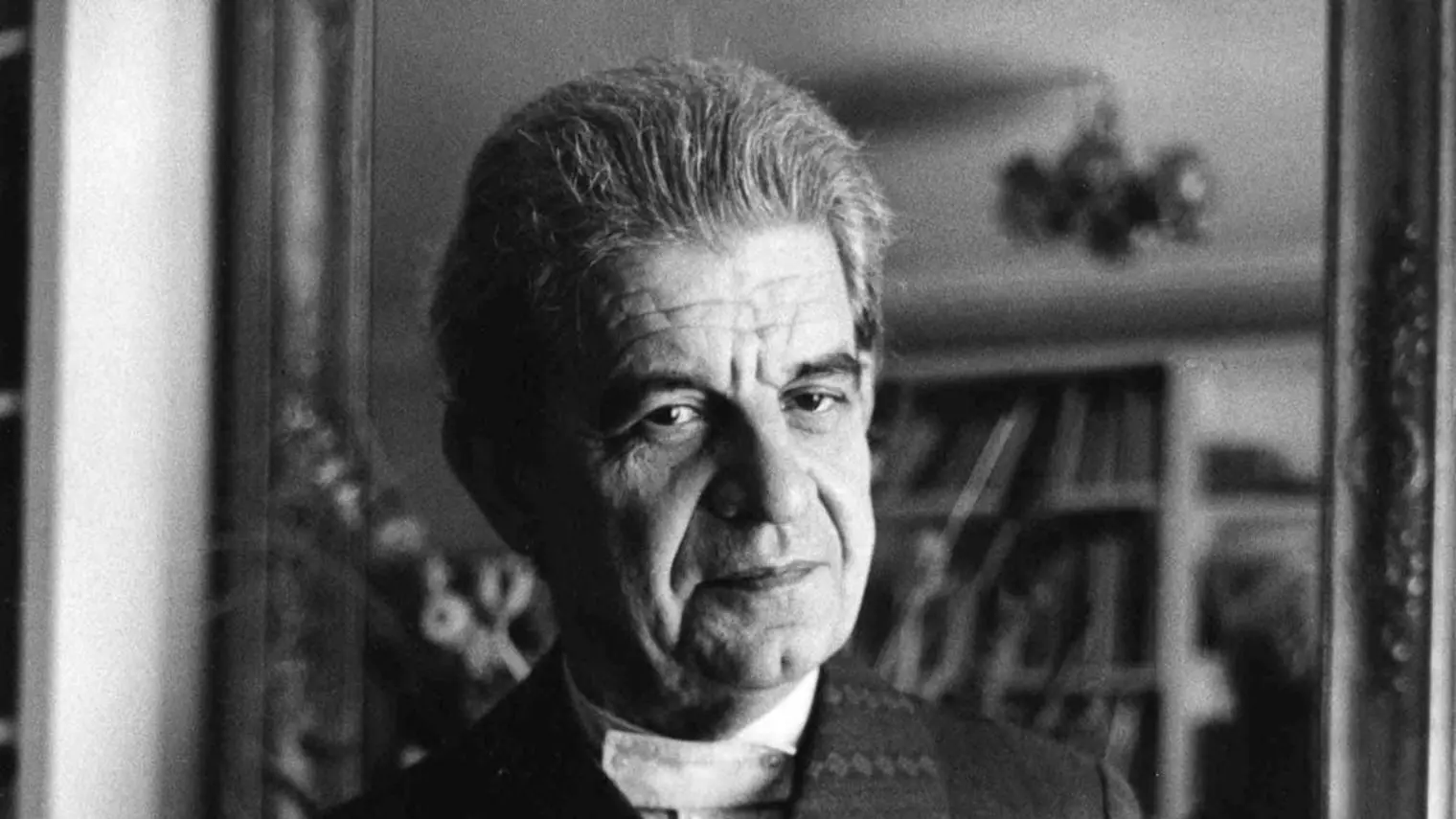
Per Lacan la Versagung costituisce il punto di svolta, il passaggio dalla tragedia antica alla tragedia moderna, contemporanea. Nella tragedia antica l’eroe eredita una colpa di cui non sa nulla, un debito che lo precede e che è chiamato a pagare, sacrificando la vita prudente, saggia, temperata entro i cui limiti (timore e pietà) sa mantenersi l’uomo comune, da buon maître. Ma in questo destino tragico, l’ Até, l’eroe trova tracciata la sua strada, la via della realizzazione del suo essere, che grazie o malgrado il suo destino lo consacra come unico, eccezionale, come una voce fuori dal coro.
La tragedia moderna, così come è rappresentata da Claudel in Sygne de Coûfontaine, nell’ Ostaggio, comincia anch’essa da qui, ma va ben oltre, ferocemente oltre il tragico antico, perché all’eroe moderno è chiesto di sacrificare ciò a cui aveva già sacrificato tutto, di rinunciare dunque al suo destino tragico, chiedendogli in cambio di votarsi anima e corpo proprio a ciò che più di ogni altra cosa aborrisce: si sottrae a qualcuno il suo desiderio e, in cambio, si dà lui a qualcun altro – all’ordine sociale, nel caso specifico.
“Sembra una cosa di poco conto, perché la incontriamo tutti i giorni, ma raramente viene espressa così. Penso che abbiate capito quello che ho detto: si toglie al soggetto il suo desiderio e, in cambio, lo si lancia [scilicet: lui, il soggetto] sul mercato, dove viene messo all’incanto.” 7
È ciò che, sorprendentemente, Lacan chiama castrazione: non la castrazione da cui nasce il desiderio, ma la castrazione del desiderio.
È questa castrazione che a un certo punto ci siamo trovati a dover subire, come psicanalisti, con l’entrata in vigore della legge Ossicini. Tutto ciò per cui e su cui avevamo sacrificato la nostra vita, tutto ciò che costituiva il nostro destino e il nucleo del nostro essere – tutto ciò che per noi ha nome psicanalisi –, ebbene ci è stato tolto, per consegnarci alla cosa che più aborriamo e che si chiama “psicoterapia”. A un certo punto, tutto ciò che era condizione, è diventato perdizione. Penso che abbiate capito quello che ho detto: si toglie all’analista il suo desiderio e, in cambio, lo si lancia sul mercato delle psicoterapie, dove viene messo all’incanto. Con “psicoterapia” non intendo un “metodo di cura” tra gli altri (se fosse semplicemente questo, non ci sarebbe stato bisogno di una legge Ossicini), ma “una pratica imperialista dalla finalità conformista (…) adattata ai bisogni dell’igiene sociale”, secondo le parole di Lacan8. E più precisamente quella pratica che ha il compito, politico in definitiva, di riallineare, di riconformare un soggetto al discorso del padrone.
Non c’è dubbio che quella che viene chiamata “nevrosi” è una forma di rifiuto della psicologia di massa e che il nevrotico è qualcuno che l’ordine sociale attuale – non tanto quello rappresentato dalle psicoterapie di Stato, ma da un transfert nei confronti dello Stato psicoterapeuta9 − non è più disposto a tollerare, proprio perché in lui qualcosa non va, “non funziona”, e questo qualcosa si chiama sintomo. Per il sintomo, per il nevrotico, se così si può dire, non (c’) è più tempo: si è finalmente compreso che è il potenziale depositario di un’istanza politica sovversiva, che va dunque eliminata prima che possa giungere al sapere.
Il sintomo dissimula, nella nevrosi, che la questione del destino è rimasta aperta, è ancora in gioco. Il nevrotico non si è ancora deciso a rinunciarvi. Ciò che in lui “non funziona” riguarda il fatto che non fa lega, non si collettivizza, non si integra in società, resiste a farsi pervertire in utente e consumatore. La speranza di un proprio punto di individuazione personale lo sostiene ancora. Intorno a lui tutti, prima o poi, si “mettono a posto”, si “sistemano”. Lui, no. Lui non si è ancora arreso, non si è ancora adattato. All’entusiasmo conformista preferisce il disagio, il disadattamento, sceglie di rimanere un “selvaggio”, come lo definiva Freud. Così non è ancora del tutto addomesticato, non riesce a usare il cellulare, a guidare la macchina, a entrare in un centro commerciale, a badare unicamente al suo profitto, a non avere scrupoli. Malgrado i suoi sforzi, il suo sintomo glielo impedisce. Mentre tutto e tutti lo spingono a “funzionare”, a diventare un funzionario, resta indietro, completamente inattuale, obsoleto, solitario, mestamente consapevole di essere anche lui, a suo modo, un rébut de la société.
Che cosa nasconde una simile follia, se non il rifiuto di tradire la fedeltà al proprio essere? Non vi è forse qui uno scivolamento del mé phúnai tragico nel patetico “Non mi avrete” ? Il dire di no, la Versagung, è custodita nel sintomo.
In quanto analisti, noi siamo i custodi della Versagung dei nostri analizzanti10, che ce la affidano, a loro insaputa e loro malgrado, nel momento in cui sentono che il primo custode a cui avevano affidato questo rifiuto, il sintomo, comincia a vacillare. Che cosa accade se il secondo custode, nelle mani del quale il sintomo è stato “trasferito”, non accetta più di sostenere questa Versagung? Accade quello che accade a un assegno: il sintomo non sarà mai più trasferibile .
Quando il sintomo, che già nel bambino esprime il rifiuto di alienarsi in un qualsiasi ideale dell’io – nella fattispecie, quello dei propri genitori −, non trova più nessuno che lo ponga in relazione al proprio destino, quando il sintomo non è ormai più che un “disturbo” da curare, allora non ci resta altro da fare che farcelo togliere, come un dente. Ma così non abbiamo più alcuna possibilità di pagare il nostro debito.
“Non siamo più soltanto nella condizione di poter essere colpevoli tramite il debito simbolico. È il fatto di assumerci l’onere del debito che può esserci rimproverato, ricusato. Insomma, è il debito stesso in cui avevamo il nostro posto, che può esserci tolto, ed è allora che possiamo sentirci totalmente alienati da noi stessi. Senza dubbio l’antica Atè ci rendeva colpevoli di questo debito, ma rifiutandolo, come possiamo fare ora, portiamo il carico di una sventura ancor maggiore, ovvero che questo destino non sia più nulla.”11
Allora, la scomparsa dell’analista – di cui Lacan dice che è egli stesso un sintomo – non esprime tanto “il disagio della cultura nella nostra modernità” (anche se mi sembra che la cultura nella nostra modernità sia perfettamente a suo agio) ma è una “pièce” della tragedia moderna del desiderio.
Note
Bello il tuo discorso, Moreno. Ho rivissuto l’emozione del momento in cui l’hai enunciato, l’emozione di riconoscere la singolarità dell’analista che rifiuta ogni accomodamento conformista. Ma, poi, a mente fredda ho pensato: “Questa è solo metà del discorso, la metà destruens. Come può essere la metà construens, quella che dice come stanno insieme questi “rifiuti” che siamo noi analisti?” Come si fa legame sociale tra analisti? Per non rimanere isolati – ricorda quel che diceva Freud a Groddeck – secondo questo discorso della Versagung, che tu giustamente vuoi custodire – ci si dovrebbe far portare in qualche discarica, magari abusivamente scavata da qualche mafia (leggi: corporazione professionale). Ho capito bene? Antonello Sciacchitano
Penso che il legame sociale tra analisti si faccia – o si rinsaldi – a tavola, a pranzo o a cena, come del resto è successo anche a noi un paio di settimane fa, dopo che per tanti anni ci eravamo persi di vista (ma non di ascolto, almeno per me). Intendo dire che non esiste un legame speciale tra ANALISTI, come se riguardasse una determinata categoria, ma che il legame sociale si fa “laicamente”, cioè popolarmente (da laikòs, “del popolo”), per ciascuno e per tutti allo stesso modo, in quanto “semplici” soggetti “non classificabili” che investono – non importa per quale ragione : la più esecrabile – tra di loro dei transfert.
In fondo è la stessa questione della legge Ossicini : non posso costituire un legame sociale con chi voglio, ma solo con chi è autorizzato per legge. Che la stragrande maggioranza della “gente” creda nell’esistenza di un esperto di psicologia (“psicologia” = psiche = pensiero = legame sociale) è strabiliante. Maria Antonietta Trasforini, in un libro esilarante di qualche decennio fa – “La professione di psicoanalista” – si era spinta ad affermare che : “lo psicoanalista sembra oggi aver acquisito una legittimità sociale: è l’esperto del più immateriale degli ambiti, quello della soggettività e delle sofferenze”. Trasforini ha avuto il coraggio, o l’ingenuità di dirlo : un ESPERTO DELLA SOGGETTIVITA’ E DELLE SOFFERENZE(!). Forse non sapeva che è così che si compiace di definirsi O’Brien, il Grande Fratello, mentre tortura Winston, in “1984” di Orwell. Del resto, Freud l’aveva già detto : “mai stato così sadico!”
Anni fa, in un breve testo avevo scritto : A qualcuno che si presentasse come “psicologo” a un aborigeno (possiamo figurarcelo, nella più classica delle vignette, con le sembianze di un Baluba congolese), quest’ultimo potrebbe del tutto legittimamente, e senza un filo di irriverenza o di ironia, replicare: “Anch’io sono psicologo”. La morale è la seguente : com’ è possibile che la Psicologia, ovvero il pensiero individuale di ciascuno, sia diventata una materia da specialisti? Ecco perché, all’inizio di ogni analisi, si passa un sacco di tempo a demolire la credenza che l’analista stia curando un “disturbo psichico”, per scoprire che questa credenza è la massima resistenza, la principale opposizione a creare, tra analista e analizzante, quel nuovo legame sociale detto (maldestramente) : “psicanalisi”.
Dunque non solo non esiste, ma non può esistere un legame sociale tra analisti: non appena lo si pensa in questi termini, solo le scuole e le associazioni di psicanalisi che si prefiggono il compito di “formare” degli analisti, possono assicurarlo. Ecco perché approvo il tuo essere fiero di definirti un analista “free lance” : penso che non si tratti di una provocazione, ma di una (dura) conquista.
Ma allora, come “si forma” un analista? La mia risposta, è che “si forma da sé… beninteso, non senza qualcun altro”; mentre non penso, nel modo più radicale, che delle istituzioni preposte in tal senso possano formare degli analisti; chi ha la pretesa di formare un soggetto (un “Formatore”, un “Didatta”) può solo formarlo al suo ideale dell’io (sfioro solo la questione).
Mi limito a rammentare l’inizio. C’è innanzitutto (o meglio : c’era) l’analisi personale, che parte dalla parola di un altro, ascoltata o letta; essa infligge, per la prima volta nella mia vita, un segno di distruzione rispetto a tutto quello che finora sono stato : è un inizio, una “chiamata”. Se accolta, non posso che rispondere : “vengo qui per essere finalmente distrutto”. E’ come nel proclama degli alieni Borg : “la tua vita, così come è esistita finora, non sarà più la stessa e tutte le tue carattersistiche psicologiche e fisiologiche verranno assimilate”.
“I Borg sono una specie cyborg dell’universo fantascientifico di Star Trek. Appaiono per la prima volta sullo schermo nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation. Sono considerati i nemici più temibili della Federazione dei Pianeti Uniti.”
Noi siamo i Borg : la Federazione dei Pianeti Uniti è avvisata. E anche la generazione successiva, se ha orecchie per intendere.
Moreno Manghi